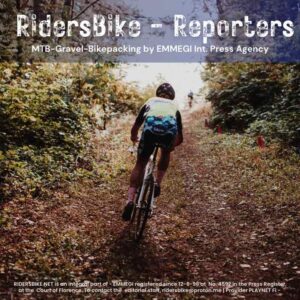Il cavallo era una insegna di Napoli storica
Carlo I, venuto a Napoli, ammirando un maestoso cavallo, insegna della città, vi facesse scrivere il seguente distico:
Hactenus effrenis, domini nunc paret habenis
Rex domat hunc aequus Parthenopensis equum.
Venne così egli nella determinazione di proporre il cavallo napoletano, il quale, ad un tempo, doveva raffigurare la città di Napoli, di cui era glorioso simbolo e significare la giustizia del re, mediante la simiglianza delle voci equus ed æquus. E, per rendere più chiaro questo pensiero, un po’ stentato in verità, fece scrivere all’intorno EQVITAS • REGNI • Dalla quale rappresentanza venne a questa moneta di rame il nome di cavallo che durò per cosi lungo tratto di tempo6.
Cosi dal Carafa fu rimesso sulla moneta il simbolo cittadino che, come ho dimostrato in un mio lavoretto sulle monete del Ducato Napoletano, ebbe già a figurare su monete del XII secolo, e su di un prezioso denaro, coniato quando Napoli, nel 1251, ribellossi agli Svevi, ergendosi a Comune, sotto la protezione di Innocenzo IV.
I cavalli di Ferdinando I d’Aragona furono coniati nelle zecche di Amatrice, Aquila, Brindisi, Napoli7 e, come dimostrerò in seguito, mediante un prezioso e, sinora unico esemplare della mia collezione, anche nella zecca di Sulmona.
In ogni libbra tagliavansi 180 cavalli, 12 dei quali formavano un grano. Di modo che l’intera libbra di rame monetato, veniva ad essere rappresentata dal valore nominale di 15 grana. Detta libbra veniva a costare alla Regia Curia circa 13 grana8, e quindi vi era un utile di solo due grani.
Fu coniata questa nuova moneta per la prima volta ai 18 di aprile di detto anno 1472, siccome si rileva da lettera della R. Camera della Sommaria9; «havendo vostra maestà mandato se facesse moneta de pizoli in nostra ceccha in la forma data per vostra maestà fo comenzato ad farese a 18 de aprile. »
Ebbero le nuove monete gran voga durante il regno del primo Ferdinando; ma il rapido succedersi della signoria francese e del nuovo dominio aragonese, la facile concessione di zecca, durante l’invasione di Carlo VIII, ed in ispecial modo la riduzione considerevole del peso, ne cagionarono ben presto il discredito.
Già Carlo VIII si avvide del danno che ne veniva al commercio e cercò di ripararvi. Ho trovato di lui, nelle copie de’ privilegi, conservate nell’archivio di Napoli, un interessantissimo documento, con cui, addì 6 maggio 149510, si toglie a Sulmona la concessione datale di coniar moneta, e ciò a cagione della diversità e della adulterazione avvenuta per le tante zecche e si ordina che si coni moneta solo nelle zecche di Napoli ed Aquila.
Il Summonte, nella sua storia di Napoli11, dice che Alfonso coniò un cavallo, coll’effigie sua e l’ epigrafe ÆQVITAS REGIS LÆTITIA POPVLI. Dice di aver posseduto questa moneta; ma è possibile ch’egli abbia male interpretato le epigrafi di qualche altro cavallo o logore o poco intelligibili per riconio posteriore12. Ad ogni modo nessun esemplare se ne conosce al giorno d’oggi.
Di Ferdinando II si conoscono soltanto due cavalli coniati a Brindisi, di cui uno, posseduto già dal Fusco13, è ora nella raccolta privata di S. A. il Principe di Napoli. E fu tralasciato evidentemente il conio dei cavalli da questi due sovrani, a cagione della soverchia abbondanza di moneta siffatta, sia per le numerose emissioni del primo Ferdinando, sia per quelle recentissime ed anche eccessive di Carlo VIII; poiché, se si fosse subito bandita tutta la moneta di rame del monarca francese, ne sarebbe venuto considerevole danno al commercio del reame, come ben chiaramente addimostrano i ricorsi delle città di Chieti e di Aquila a Federico d’Aragona, perchè si permettesse ancora la circolazione de’ cavallucci di Carlo VIII14.
Annuì da principio Federico apponendo però il placet regiae maiestati colla riserva ad eius beneplacitum. Intanto Notar Giacomo15 avverte che Federico, sul principio del suo regno, vietò si spendessero più «li cavallirazi de rame che haveano facti li francisi, con lo signo de la croce et deli III gigli, de rame.»
Si vede che la quistione de’ cavalli diè parecchio fastidio a Federico, che non sapeva come provvedere con soddisfazione di tutti. Notar Giacomo osserva che, in sulla fine del 1496, Federico venne in Napoli «per conciare multe cose et maxime le monete.»
Le città di Chieti e di Aquila chiedevano intanto novella concessione di zecca, ed io trovo nelle Cedole di Tesoreria per l’anno 1497, addì 23 ottobre, che «Lodovico de Jacobo de Marco da 500 ducati quali dona a la regia Corte per la gratia che el S. R. li ha facta che pocza bacter cavallucze in Apruzzo16.»
Passano intanto pochi mesi, ed ecco che, secondo narra Notar Giacomo, «addi XIII de iennaro 1498 fo pubblicato banno che perlo advenire in nesciuno loco del regno se facessero cavalluzi et che ciascheuno li devesse spendere et pigliare dudece per uno tornese (ossia 24 per grano) et questa per la quantità senne faceva et diminucione della rame17;» e poi addi 13 marzo dell’anno medesimo: «ando banno reale che li cavalli non si spendessero et nesciuno le pigliasse per certe cause in lo banno contente18.»
Evidentemente Federico, vedendo caduta in discredito questa moneta, che era a stremo tale ridotta, da non corrispondere più nemmeno alla metà dell’intrinseco dei cavalli di Ferdinando I e che perciò di nuovo impunemente si falsava, determinò di bandire tutta quella che era in commercio per coniare poi nuova moneta di rame a miglior ragione dell’antica. E Notar Giacomo ci dice che: «adì XXI de sectembre 1498 ando banno reale come sua maestà havea facto fare per utilita del regno una moneta erea nominata sextina che quilli si havessero da spendere sei per uno tornese19. » Si coniò questo doppio cavallo o sestina nelle zecche di Napoli e di Sulmona.
Rivisse cosi questa moneta, e per lungo tratto di tempo, tra continue mutazioni di Signoria, con tipi assai vari, se ne continuò il conio, restando però sempre immutabile, presso il volgo, la denominazione di cavallo.
Fonte
it.wikisource.org